Nel 1876 Max nasce a Quimper, Francia, da una famiglia ebrea. Dopo le scuole primarie vince una borsa di studio e si iscrive alla scuola coloniale di Parigi che abbandona, però, nel 1897 per dedicarsi alla carriera artistica, pur patendo la fame.
Sotto pseudonimo comincia a collaborare alla rubrica artistica del “Moniteur des arts”, e nel 1901 incontra Pablo Picasso, con cui lega fin da subito.
Fa lo scrivano, il precettore, il magazziniere. Divide, proprio con Picasso, un’umilissima camera in Boulevard Voltaire. Conosce tutti gli artisti dell’Avanguardia, da Apollinaire ad André Salmon, da Braque ai poeti del Bateau Lavoir. Nel 1909 sostiene che Cristo gli è apparso in una visione; anni dopo, con Pablo come padrino, si converte al cattolicesimo.
Due gravi incidenti automobilistici gli consentono di essere riformato durante la Prima guerra mondiale; anche per questo sarà lui, durante il conflitto, a mantenere i rapporti tra gli artisti sotto le armi.
Nel 1916 diviene amico di Modigliani, che lo ritrae in uno dei suoi celebri dipinti.
Intanto continua la sua poliedrica attività. Scrive commedie e sceneggiature; dipinge ed espone; pubblica alcune opere. Nel biennio 1926, 1927 viaggia in Italia e in Spagna.
Nel 1944, nonostante la sua conversione, viene arrestato dalla Gestapo e muore a Drancy, di polmonite.
I suoi amici lo descrivono come un funambolo, un uomo profondamente triste che riesce, però, a far ridere tutti con le sue stravaganti battute. Per farsi notare, da giovane, frequenta tutti i funerali di cui ha notizia, vestito di nero, ma calzando guanti rosso fuoco. “Mi hanno notato, ma nessuno si è interessato a me” pare abbia poi confessato agli amici.
La critica ha sempre collocato Jacob in una sorta di ambiguità ideologica, in bilico tra i pilastri dell’impressionismo e le aspirazioni delle avanguardie. In molte lettere Max sosteneva di essere attratto dalla sperimentazione di cubismo e astrattismo, ma di essere in fondo visceralmente innamorato dell’impressionismo.
Ecco che allora ci viene in soccorso una chiave di lettura delle sue opere insolita, nuova. Quella esoterica. Jacob, nato in una antica famiglia ebrea dalle radicate convinzioni religiose, con una cultura basata sulla tradizione, improvvisamente ha, come abbiamo visto, una visione di Cristo – da intendere come un Grande Iniziato – di cui avverte il profondo legame con la cultura ebraica a lui ben nota ma che, incarnandosi uomo, può partecipare finalmente dei dolori della condizione umana. È una vera e propria folgorazione, seppur, come spesso capita, la sua nuova condizione di convertito genera una personalità allo stesso tempo dimezzata e raddoppiata. Per questo tronca – crede di farlo – con la sua precedente personalità ma conserva, coscientemente o meno, un bagaglio di credenze che sono alla base della sua cultura d’origine. Sul tronco che si regge su queste radici, innesta dei nuovi rami, non sempre esenti da fenomeni di rigetto. La sua è certamente una condizione scomoda. Ecco spiegata la sua costante tensione intellettuale a conciliare gli opposti che lo caratterizzano. E questo tentativo di sintesi, di riunificazione emerge con forza da alcune sue opere. Pensiamo a quei frettolosi disegni, a penna e matita, che al di là del loro intrinseco valore estetico, devono considerarsi come degli appunti, come pagine del suo diario intimo e segreto.
Se osserviamo alcuni dei suoi disegni di inizio secolo – proprio negli anni della sua visione – è evidente il travaglio spirituale di Max, ancora combattuto (il battesimo risale al 1915) tra il suo legame alla Cabala e quell’anelito al dio misericordioso impersonato dal Cristo. Prendiamo un piccolo acquerello del 1909, intitolato “Natura morta”. L’angolo di un tavolo su cui poggia una lampada ottocentesca e due bottiglie. Un frammento di giornale, datato 13 aprile. Una sedia con pomoli che ne ornano la spalliera. A sinistra, in alto, tre frecce realizzate a triangolo e che indicano inequivocabilmente la luce proveniente dalla lampada. Il pomolo di sinistra contiene un viso umano. L’altro potrebbe rappresentare, con le sue grandi ombre, il mondo. La lettera “a” è posta a fianco della lampada, sul tavolo. Che significato esoterico può assumere questa scena?
Prendiamo un piccolo acquerello del 1909, intitolato “Natura morta”. L’angolo di un tavolo su cui poggia una lampada ottocentesca e due bottiglie. Un frammento di giornale, datato 13 aprile. Una sedia con pomoli che ne ornano la spalliera. A sinistra, in alto, tre frecce realizzate a triangolo e che indicano inequivocabilmente la luce proveniente dalla lampada. Il pomolo di sinistra contiene un viso umano. L’altro potrebbe rappresentare, con le sue grandi ombre, il mondo. La lettera “a” è posta a fianco della lampada, sul tavolo. Che significato esoterico può assumere questa scena?
Per comprendere il mondo, per avere conoscenza del cosmo, è necessaria la luce. Una luce particolarmente intensa, che soltanto con la giusta attenzione si può intravedere tra gli oggetti e che necessita di un punto, iniziale, da cui scaturire.
Ecco il significato della lettera “a”, la prima dell’alfabeto.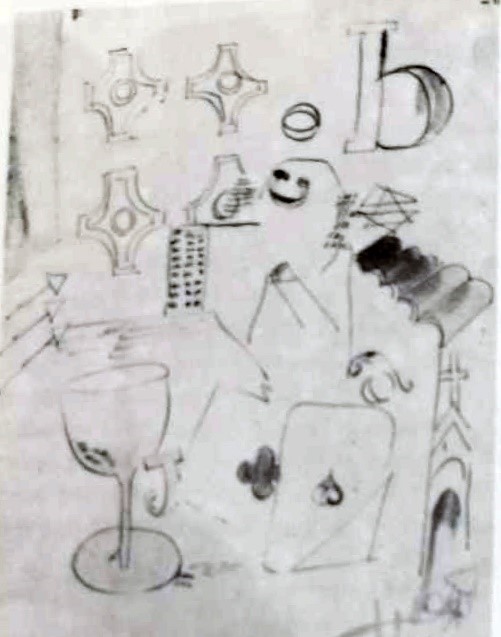
Con il medesimo approccio si deve osservare lo “Studio per natura morta” del 1909. In questo disegno Jacob cerca di conciliare ebraismo e cristianesimo. Chiarissimi i riferimenti al Tempio di Salomone, con l’indicazione delle due colonne, J e B. Le tavole della Legge sono facilmente individuabili in quella sorta di stele, che campeggia nel centro. Vi sono poi quattro sezioni di colonne che, tuttavia, potrebbero anche riferirsi ai quattro elementi fondamentali. Una coppa (il Santo Graal) in primo piano pone l’accento sul sacrificio di Gesù. Una chiesa cattolica (indicata dalla croce) è dominata dalla copertura, da tegole su cui poggiano triangoli. Si vedono anche carte da gioco (riferimento forse ai Tarocchi?). Anche qui, tre frecce a triangolo rivolte verso l’alto. Come se Jacob volesse tradurre il suo insopprimibile anelito all’elevazione spirituale.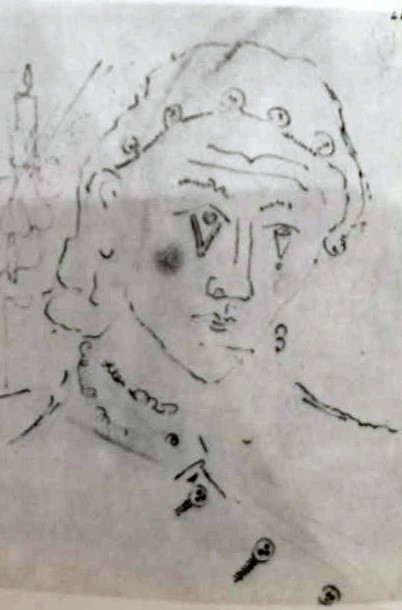 Esaminiamo ora “Il ritratto”, sempre del 1909, un disegno a china e matita rossa. Vi è raffigurato un viso di donna con una candela accesa alle spalle. Ritorna il riferimento alla Luce: pretesto tecnico ma anche strumento per la ricerca di una spiritualità. Il viso è composto in buona parte da simboli emblematici; il numero tre evidente sul collo, i tre circoletti posti a triangolo a simulare l’attaccatura dei bottoni dell’abito, le borse sotto gli occhi (assolutamente innaturali) a forma, di nuovo, di triangolo.
Esaminiamo ora “Il ritratto”, sempre del 1909, un disegno a china e matita rossa. Vi è raffigurato un viso di donna con una candela accesa alle spalle. Ritorna il riferimento alla Luce: pretesto tecnico ma anche strumento per la ricerca di una spiritualità. Il viso è composto in buona parte da simboli emblematici; il numero tre evidente sul collo, i tre circoletti posti a triangolo a simulare l’attaccatura dei bottoni dell’abito, le borse sotto gli occhi (assolutamente innaturali) a forma, di nuovo, di triangolo.
Il messaggio forse più complesso, però, è nascosto in disegno acquarellato del 1910. 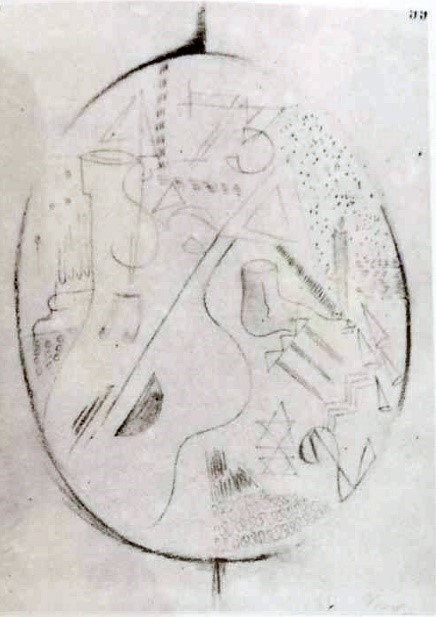 Una composizione dove la critica vede, non a torto, anticipazioni di Braque e persino dei Futuristi. Tuttavia è possibile leggervi un messaggio spirituale ed esoterico, di nuovo legato al tema del numero tre. Un piede, a rappresentare la materialità dell’uomo, rivolge l’alluce verso la candela accesa e, proprio lì vicino, vi sono coni con le punte rivolte verso l’alto, verso la luce.
Una composizione dove la critica vede, non a torto, anticipazioni di Braque e persino dei Futuristi. Tuttavia è possibile leggervi un messaggio spirituale ed esoterico, di nuovo legato al tema del numero tre. Un piede, a rappresentare la materialità dell’uomo, rivolge l’alluce verso la candela accesa e, proprio lì vicino, vi sono coni con le punte rivolte verso l’alto, verso la luce.
Le frecce a triangolo, sempre tre, indicano l’ascesa verso il Superiore che può essere raggiunto grazie a strumenti particolari, quali il Sigillo di Salomone, il triangolo, la chitarra e la chiave di violino (a 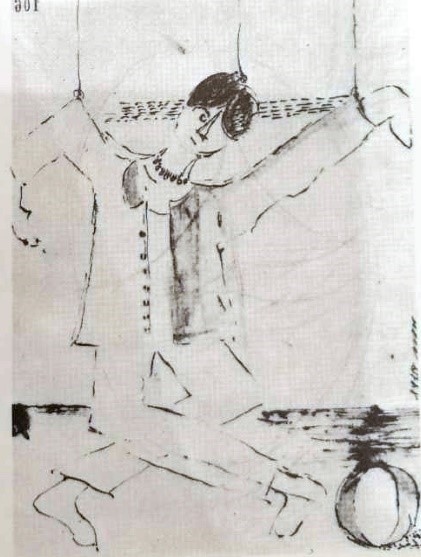 rappresentare la percezione dell’armonia del cosmo).
rappresentare la percezione dell’armonia del cosmo).
Sono numerosi, in questo periodo della sua attività artistica, anche i disegni di marionette, che non paiono di legno, ma partecipi di un’umanità sofferente e derisa, sacrificata e incompresa. Sembrano crocifissi, e rimandano alla visione del Cristo.
Jacob, come detto, era di temperamento triste, molto sensibile e vulnerabile ma, agli occhi del mondo, della cerchia di amici e conoscenti, allegro e dalla battuta sempre pronta.
Se, prima facie, i disegni delle marionette possono far pensare a una serie di autoritratti, non bisogna trascurare i significati più profondi per comprendere che, con la sua opera, Max Jacob ha sempre cercato di immedesimarsi nel Cristo incarnato, un Grande Iniziato, inteso come strumento di Conoscenza e come unico legame possibile tra la Tradizione e il Nuovo Verbo.

